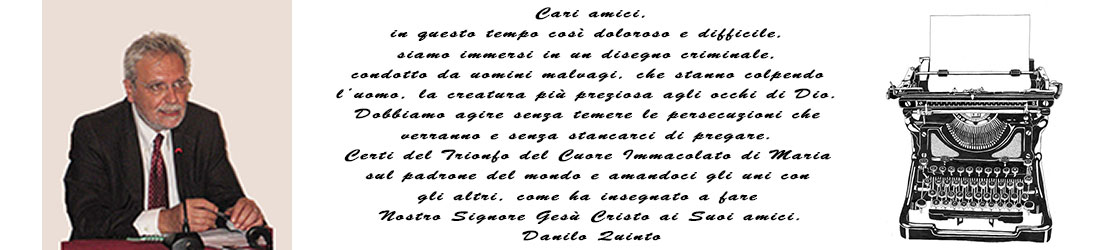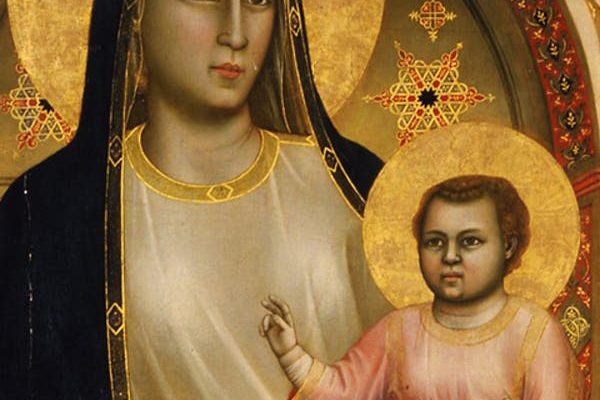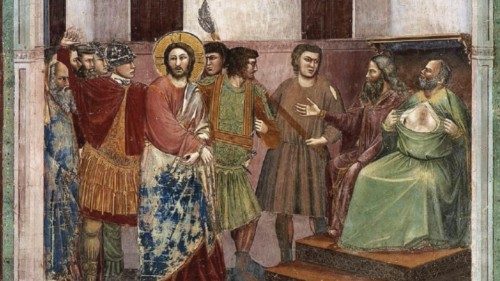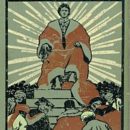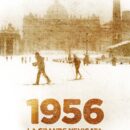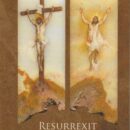Non nobis Domine 28

Pensando alla situazione di oggi della Chiesa – quella iniziata ben prima del Concilio Vaticano II e proseguita con una serie di successori di Pietro che hanno continuato a guardare al mondo più che al Cielo – mi viene in mente una delle pagine di teatro che amo di più. La vidi nel 1978, nell’edizione del Piccolo Teatro. Due grandi attori, Tino Schirinzi e Renato De Carmine e una bellissima scenografia. All’interno di un parallelepipedo di pareti grigie – scriveva un critico dell’epoca – si vede sul palcoscenico una specie di natura morta, una forma ovale, una sorta di catino pieno di terra. Una terra grigia, infeconda, consunta, bruciata, cinerea. Un paesaggio post-atomico, suggerito anche dal colore grigio della sabbia, che ricorda la cenere di un mondo distrutto. Il tradizionale albero di “Aspettando Godot”, in quella messa in scena diveniva un simbolo di disperata desolazione, con due soli rami che si levavano come braccia al Cielo in un gesto misto di invocazione e tormento. L’umanità dei due vagabondi – che s’incontrano in una strada di campagna per un appuntamento, di cui non conoscono né ora, né luogo, né colui che si dovrebbe presentare – è un’umanità malata e desolata, vuota e volgare. Un’umanità pervasa da un’attesa: l’arrivo di un uomo che porterà i vagabondi a casa sua, darà loro qualcosa di caldo da mangiare e li farà dormire all’asciutto. L’attesa è inutile: quell’uomo non arriverà mai e i due vagabondi resteranno a vivere la loro miseria terrena.
Nella nostra realtà umana, viviamo questo tempo di attesa. Viviamo quello che ha vissuto Gesù sulla Croce, quando grida a gran voce: “Elì, Elì, memà sabactàni”. Sappiamo che l’attesa non sarà inutile, come nella commedia di Samuel Beckett. È un’attesa feconda, intrisa di gioia sofferente – come dice san Paolo – di condivisione di quella Croce, senza la quale il Cristianesimo non ha alcuna ragione di essere, come ben sanno i membri di questa Chiesa, che quasi interamente la ignorano, pervasi come sono dalle cose della terra.